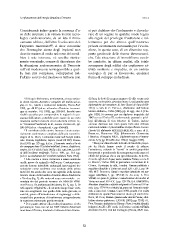Page 54 - 07_IV_2013
P. 54
Lo sfruttamento dell’energia idraulica a Demonte SAGGI Considerando infine quanto la coerenza d’u- si può dubitare che l’isolamento e il perdu- so delle strutture e la vistosa inerzia tecno- rare di un regime in qualche modo legato logica condizionarono, da un lato il rinno- alle regole del privilegio frustrarono e ral- vamento edilizio, dall’altro l’evoluzione del- lentarono più che altrove quell’iniziativa l’apparato meccanico , si deve convenire privata sicuramente necessaria per l’evolu- 205 che l’immagine stessa degli impianti non zione, in questo caso, di un dinamico rap- dovette mutare di molto nel corso dei secoli. porto gestionale delle risorse idromeccani- Non è mio interesse, né sarebbe storica- che. Tale situazione di immobilismo avreb- mente verosimile, cercare di dimostrare che be condotto, in ultima analisi, alla totale la situazione socioeconomica di Demonte scomparsa degli edifici che ospitavano at- nell’età moderna sia sovrapponibile a quel- tività molitorie e impedito, in un ambito la, ben più complessa, sviluppatasi nel- ecologico di per sé favorevole, qualsiasi l’ultimo scorcio del medioevo; tuttavia non forma di sviluppo industriale. 1 Si fa qui riferimento, ovviamente, al noto artico- di Susa, la dotò di un gran numero di ville «cum areis lo di M. BLOCH, Avvento e conquiste del mulino ad ac- suarum, molendinis, piscationibus»: Le più antiche carte qua, in ID., Lavoro e tecnica nel medioevo, Roma-Bari diplomatiche del monastero di San Giusto di Susa (1029- 1959, pp. 48-87 (ed.or. «Annales d’histoire économi- 1212), a cura di C. CIPOLLA, «Bullettino dell’Istituto que et sociale», VII, 1935), pp. 538-563. Benché esso Storico Italiano», XVIII (1986), pp. 61 sgg., doc. 1 (9 lu- risulti esaustivo per comprendere le ragioni e le po- glio 1029). Si conosce poi un diploma imperiale del sizioni dell’autore, potrebbe però essere di un certo 1047 con cui Enrico III, confermando possessi e privi- interesse anche la lettura di un ulteriore scritto: ID., legi all’abbazia di San Solutore di Torino, incluse Le “invenzioni”medievali, in ID., Lavoro e tecnica cit., pp. «omnes decimas tam intra quam foris eius civitatis 180-199 (ed.or. «Annales cit.», pp. 634-643). cum molendinis et piscatonibus in ipso fluvio Turia»: 2 Il contributo dello storico francese è stato sostan- Henrici III diplomata MXXXLX-MXLVII, a cura di H. zialmente confermato e ampliato dalle più recenti in- BRESSLAU, Hannover 1926, (Monumenta Germaniae dagini di G. DUBY, L’economia rurale nell’Europa medie- Historica, di seguito MGH, Diplomata regum et impera- vale. Francia, Inghilterra, impero (secoli IX-XV), Roma- torum, 5/I), pp. 251-252, doc. 198a (1 maggio 1047). Bari 1970, pp. 327 sgg. (ed.or. L’économie rurale et la vie 5 Essi, pur dimostrando la bontà del modello propo- des campagne dans l’Occident médiéval. France, Angleterre, sto da Bloch, hanno avuto il merito di ridurne empire, IX-XV siècle, Paris 1962); e di J. LE GOFF, La civil- l’astrattezza, calando la “teoria” in ambiti geopolitici tà dell’Occidente medievale, Torino 1981, pp. 214 sgg. ben precisi e ponderando di conseguenza reali cause ed (ed.or. La civilisation de l’Occident médiéval, Paris 1964). effetti del processo che si sta qui delineando. Si fa rife- 3 Alle macine a mano iniziarono a essere sostituite rimento agli studi Acque, ruote e mulini a Torino, a cura di quelle mosse da animali o dall’acqua. Contemporane- G. BRACCO, Torino 1988, in particolare i contributi di R. amente furono introdotte sostanziali innovazioni tec- COMBA, Il principe, la città, i mulini. Finanze pubbliche e nologiche: come conferma una scultura della prima macchine idrauliche a Torino nei secoli XIV e XV, I, pp. 79- metà del XII secolo che orna un capitello della navata 103; M.T. BONARDI, Canali e macchine idrauliche nel pae- laterale destra della basilica di Sainte-Marie-Madeleine saggio suburbano, I, pp. 105-128; G. ALLIAUD, A. DAL a Vézelay (fig. 2), alla ruota ad acqua orizzontale – co- VERME, Le spese di gestione e manutenzione dei mulini di nosciuta sin dal periodo romano: cfr. MARCUS VITRU- Torino nei secoli XIV-XV, I, pp. 129-176; S.A. BENEDETTO, VIUS POLLIO, De architectura libri decem, lib. X, cap. 5, De Macchine idrauliche e attività artigianali a Torino nel XV se- rotis aquariis et hydraletis – il cui moto lungo l’asse verti- colo, I, pp. 177-194 e a Mulini da grano nel Piemonte medie- cale era congruente con quello della mola girevole, si vale, a cura di R. COMBA, Cuneo 1993, passim. Per realtà sostituì, grazie all’introduzione di ingranaggi e diffe- differenti da quelle Piemontesi si citano gli studi di G. renziali che permisero di trasformare ortogonalmente BERTI, M. GORI, Mulini e frantoi nella città di Pistoia, «Bol- la rotazione orizzontale, quella verticale. lettino storico pistoiese», LXXVIII (1976), pp. 72-92; A.I. 4 Per quanto attiene alla realtà piemontese, si cita PINI, Energia e industria tra Sàvena e Reno: i mulini idraulici per esempio l’atto con cui nel 1029 Olderico Manfredi bolognesi tra XI e XV secolo, in Tecnica e società nell’Italia marchese di Torino, fondando l’abbazia di San Giusto dei secoli XII-XVI, Atti del convegno (Pistoia, 28-31 otto- 52